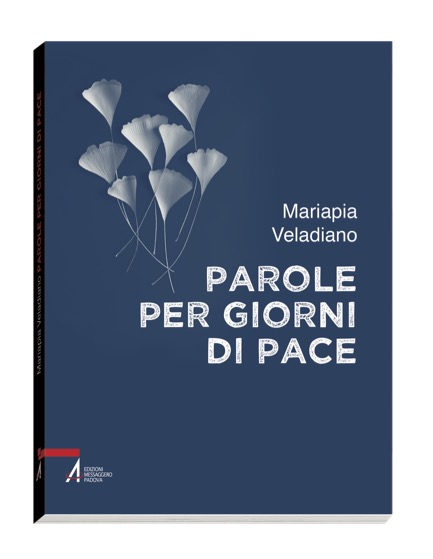Il filo rosso di queste «Riletture» è la domanda sulla vita e su Dio. I romanzi sono più attrezzati dei trattati in queste cose, perché com’è ovvio partono sempre dalla vita, e ci rimangono dentro, e non hanno la pretesa di dare una risposta. Peggio ancora, la risposta. Mentre ai trattati, soprattutto teologici, è richiesto di chiudere in qualche modo il cerchio, di dare una risposta, fosse pure prudente, e spesso proprio non lo è.
La letteratura, quindi. E con ostinazione si va in cerca di romanzi in cui la dimensione di fede, nella forma dell’interrogazione o dell’esperienza, sia presente in modo non occasionale o peggio strumentale. Ma niente. C’è pochissimo nella smisurata produzione di romanzi che in Italia vengono pubblicati, e c’è da chiedersi perché, dal momento che siamo la culla del cattolicesimo e che l’invocazione dell’identità cristiana è diventata ossessiva e ipertrofica negli ultimi anni.
E si finisce nel passato, sempre. Manzoni, Fogazzaro, Parise, Monicelli, Silone e poi, fuori confine ma la letteratura non ha confini, Bernanos, Chesterton, Seipolt, O’Connor. Con l’eccezione, meravigliosa, di Marilynne Robinson, americana, autrice contemporanea immensa, calvinista, lo dice spesso quando parla di sé, la cui scrittura è tutt’uno con la conoscenza e l’esperienza religiosa e di fede. E poi, oggi, c’è anche Alice McDermott, ancora americana, i cui personaggi si muovono invece dentro la cultura cattolica. In attesa della traduzione italiana del suo ultimo romanzo, Absolution, pubblicato da qualche mese, si può intanto rileggere con assoluta delizia L’ora nona (Einaudi 2019, traduzione di Monica Pareschi; cf. anche Regno-att. 12,2020,331).
Primi del Novecento, Brooklyn, quartiere poverissimo di immigrati irlandesi. L’incipit è perfetto. «Il 5 febbraio era stata nel complesso una giornata buia e umida: pioviggine fredda la mattina e cielo basso, grigio ferro per il resto del pomeriggio. Alle quattro, Jim convinse la moglie Annie ad andare a fare la spesa prima che il buio calasse del tutto. Dopo un lieve cenno di saluto le richiuse la porta in faccia» (4).
Struggente, il buio e il freddo, inquietante, perché alla premura di far uscire la moglie prima del buio si contrappone il sospetto che qualcosa non vada per il verso giusto. Perché non esce lui? D’accordo, nelle comunità cattoliche irlandesi emigrate le donne facevano la spesa. Però poi lui le richiude la porta in faccia. Il fatto è che Jim la manda via perché vuole avere un piccolo tempo tutto per sé, per morire, per aprire il gas dello struggente appartamento in cui vive e farla finita. Anche se sua moglie aspetta un bambino. Forse per quello. La ama, lo si capisce.
È un uomo bello e gentile che forse è depresso o forse è solo troppo consapevole della vita. Non sa tenersi un lavoro, uno di quei lavori da schiavi che gli immigrati dovevano accettare come fosse una cuccagna e con gratitudine. Ma lui non poteva. Non si alzava in tempo. Veniva licenziato dopo pochi giorni. Niente di che, ma quel tipo di condizione non ha margini di trattativa. Jim muore e la moglie Annie resta sola con la sua bambina nella pancia.
Ma già, in queste prime pagine d’incanto, si affacciano personaggi che fanno splendere di una luce discreta il proprio ruolo. Suor St Saviour, delle Piccole sorelle dei poveri infermi, tornava al convento dopo una giornata di questua davanti ai grandi magazzini Woolworths e voleva solo rientrare, con le gambe gonfie, la vescica piena. Ma si ferma, non passa oltre e semplicemente si lascia portare dentro la situazione, e le dà una svolta. Non le interessa il giudizio. Già tutti pronti a sussurrare con moralistica riprovazione che l’uomo si è suicidato, già tutti pronti a escluderlo dalla Chiesa (cattolica) in cui credeva: aveva acquistato un pezzetto di terra al cimitero cattolico, appena arrivato.
«Era stata una giornata greve di disperazione. Dio stesso non aveva potuto farci niente, suor St Saviour ne era convinta. Era convinta che mentre nell’appartamento al piano di sopra un giovane si liberava dal giogo di quella vita grigia… non per mancanza d’amore, ma per l’assoluta incapacità di andare avanti (…) Dio era rimasto lì, con la testa fra le mani» (15).
Grazie all’intercessione (laicamente può essere tradotta con senso di responsabilità, o con compassione, nell’accezione di «sentire insieme») della suora, Annie trova riparo e casa nel convento, dove lavorerà nella lavanderia e dove nascerà la figlia Sally, amatissima bambina che da grande dovrà trovare il proprio posto nel mondo, cosa non facile dal momento che il suo mondo naturale sembra essere il convento.
Ma intorno al convento vortica un’umanità varia e interessante, piena di attese e piccole felicità che possono rendere la vita assolutamente degna e bella. Non perfetta, e nemmeno l’amore, che alla fine sia la madre che la figlia troveranno, sarà sufficiente a metterle al riparo dalla malinconia, come viene giustamente chiamata. La malinconia non è la malattia della depressione, è il senso che qualcosa nella vita è andato, va o potrà andare storto. È un correttivo nobile al senso di onnipotenza che uccide molto, ma molto di più. Soprattutto uccide il nostro prossimo.
C’è da dire che la fede è delle donne, qui. Le suore soprattutto. Suor Lucy e suor Jeanne che rischia la propria fede fino in fondo: «Ho rinunciato al mio posto in cielo tanto tempo fa, – disse –: Per amore dei miei amici» (266). Un incanto, questo romanzo.
Naturalmente resta prosaicamente la domanda: perché la narrativa (italiana) non parla di Dio? Possiamo dare risposte diverse, ma la più ovvia, e banale, è forse che della Scrittura e della fede oggi in Italia si sa pochissimo, perché al netto di un uso strumentale e identitario che una politica senza simboli propri e senza pensiero nobile ne fa, è irrilevante, semplicemente irrilevante. E allora, ecco, il passaparola di noi lettori-cercatori, può davvero essere una gioia.
Il Regno – attualità, 15 gennaio 2024.